|
|
Il Romanico di pianura |
|
|
|
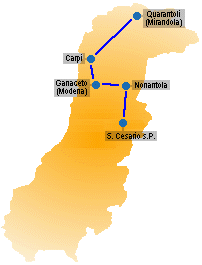
Dal punto di vista storico ed architettonico è il monumento romanico della provincia che maggiormente può
reggere il confronto con il Duomo. L'Abbazia, fondata nel 742 dall'abate longobardo Anselmo e poi dedicata a S. Silvestro,
fu più volte distrutta da incendi e saccheggi e più volte ricostruita. L'ultima riedificazione in stile
romanico risale al XII secolo, e fu iniziata pochi anni dopo i guasti del terremoto del 1117: è proprio per
ripristinare questa antica struttura che agirono i restauri condotti fra il 1914 e il 1917, tesi a cancellare le
sovrapposizioni barocche del XVII e XVIII secolo. In particolare fu sistemata la cripta, che era stata interrata nel
XV secolo e che rappresenta senza dubbio la parte più antica della costruzione, scampata anche al terremoto
del 1117: una volta portata alla luce, ha rivelato tutta la sua bellezza, con le 64 colonnine completate da capitello,
che reggono le volte a crociera; essa costituisce probabilmente l'esemplare sul quale fu modellata la cripta del Duomo
di Modena. I restauri novecenteschi si sono anche preoccupati di innalzare il presbiterio al livello originario, di
demolire le volte quattrocentesche (sostituite con capriate in legno), di abbassare il livello del pavimento, di scoprire
i poderosi pilastri a sezione cruciforme.
Chiesa parrocchiale di Ganaceto 
Per coloro che si occupano di scultura romanica, segnaliamo la presenza, nella chiesa parrocchiale di Ganaceto (sorta sui resti di una chiesa romanica del XII secolo), di un pezzo di pregio: la vasca battesimale (originariamente era un'acquasantiera), le cui figure in rilievo, che rappresentano sirene a due code, ripropongono fantasie medievali e simboli di cui i più hanno perduto il significato: le sirene alludono alla lussuria, uno dei peccati più perseguitati dalla chiesa medievale. È interessante il fatto che la stessa tipologia si ritrovi in una antefissa del Duomo di Modena, il che ha fatto attribuire l'opera alla scuola del «Maestro delle metope" (secolo XII).
Pieve di Santa Maria della Neve Il tempo e l'opera dell'uomo hanno trasformato la chiesa che, qui esistente già prima del mille, fu poi riedificata nel XII secolo. Molte manomissioni di epoca barocca (che riguardano soprattutto la facciata) e di stile ibrido hanno alterato l'originario aspetto romanico, che resta documentato ormai quasi solo dal pulpito, le cui sculture, certamente ascrivibili al XII secolo, sono opera di artisti della cerchia di Wiligelmo e sono di tale fattura da costituire motivo sufficiente per una visita. I telamoni sono di grande efficacia espressiva: l'anomala disposizione delle belle formelle degli evangelisti denuncia la provenienza da altra struttura. 
Gli edifici sono organismi viventi, che si trasformano nei secoli: ne è prova, fra le tante, la chiesa di S. Maria di Castello, chiamata la «Sagra», che ad un frettoloso colpo d'occhio all'esterno appare edificio rinascimentale; e lo è, soprattutto nella facciata segnata da lesene e rilievi in cotto che ne sottolineano la geometria. Ma, a ben guardare, si scopre che si tratta di un edificio ad impianto romanico (la consacrazione è del 1184) come risulta dalla parte absidale, dalle linee architettoniche delle fiancate con archetti pensili e dal portale, con lunetta che rappresenta la Crocifissione. Pure romanici sono il pulpito interno e il campanile, il quale risulta immenso rispetto alla chiesa, accorciata di due terzi da Alberto Pio nel XVI secolo, per ristrutturare la piazza posteriore al castello. Chiesa parrocchiale di S. Cesario sul Panaro Un recupero fu eseguito negli anni '70 sulla chiesa di S. Cesario, il cui restauro permette di "leggere" tipici elementi dell'architettura romanica: le absidi con gli strombi delle finestrelle a feritoia, gli archetti ciechi e pensili, le lesene, i giochi decorativi «a dente di sega» dei mattoni. Costruzioni di questo tipo hanno un forte valore didascalico, perché conservano e illustrano con chiarezza la «lingua» con cui si esprimeva l'architettura romanica. |
|
© 1997 - Provincia di Modena - Made by
|
|
 Sulla facciata sono degni di attenta osservazione i bassorilievi delle
facce esterne degli stipiti del portale, che rappresentano, a destra, i primi fatti evangelici e, a sinistra, episodi
della storia stessa dell'Abbazia: sono esempi pregevoli di una scultura che ha in Wiligelmo il suo diretto punto di
riferimento. La mentalità medievale affiora nel «tralcio abitato» degli stipiti interni e
dell'archivolto, rappresentazione simbolica della «selva oscura» della vita. La nascita di Cristo è
l'episodio del Nuovo Testamento che compare sullo stipite destro, scandito in scene "leggibili" sulla pietra
anche per gli analfabeti: angeli annunciatori; la nascita di Cristo; un presepe; delle pecore; dei pastori; i Magi in
adorazione. Sullo stipite di sinistra appaiono le vicende della fondazione dell'Abbazia: la donazione ad Anselmo,
la consacrazione dell'Abbazia, il trasporto delle reliquie di S. Silvestro e la loro tumulazione nel nuovo edificio sacro.
Nell'ultima formella un guizzo espressivo del linguaggio simbolico può lasciarci perplessi: un "Sansone che
smascella il leone" desunto dal Vecchio Testamento appare inopinatamente insieme a scene del Nuovo e alla cronaca di
fondazione dell'Abbazia. Ma quando le chiavi di lettura dei messaggi simbolici non erano ancora state perdute, era facile
per i fedeli vedere in Sansone la metafora del Cristo. Anche sulla facciata del Duomo di Modena
(cfr.
Sulla facciata sono degni di attenta osservazione i bassorilievi delle
facce esterne degli stipiti del portale, che rappresentano, a destra, i primi fatti evangelici e, a sinistra, episodi
della storia stessa dell'Abbazia: sono esempi pregevoli di una scultura che ha in Wiligelmo il suo diretto punto di
riferimento. La mentalità medievale affiora nel «tralcio abitato» degli stipiti interni e
dell'archivolto, rappresentazione simbolica della «selva oscura» della vita. La nascita di Cristo è
l'episodio del Nuovo Testamento che compare sullo stipite destro, scandito in scene "leggibili" sulla pietra
anche per gli analfabeti: angeli annunciatori; la nascita di Cristo; un presepe; delle pecore; dei pastori; i Magi in
adorazione. Sullo stipite di sinistra appaiono le vicende della fondazione dell'Abbazia: la donazione ad Anselmo,
la consacrazione dell'Abbazia, il trasporto delle reliquie di S. Silvestro e la loro tumulazione nel nuovo edificio sacro.
Nell'ultima formella un guizzo espressivo del linguaggio simbolico può lasciarci perplessi: un "Sansone che
smascella il leone" desunto dal Vecchio Testamento appare inopinatamente insieme a scene del Nuovo e alla cronaca di
fondazione dell'Abbazia. Ma quando le chiavi di lettura dei messaggi simbolici non erano ancora state perdute, era facile
per i fedeli vedere in Sansone la metafora del Cristo. Anche sulla facciata del Duomo di Modena
(cfr.